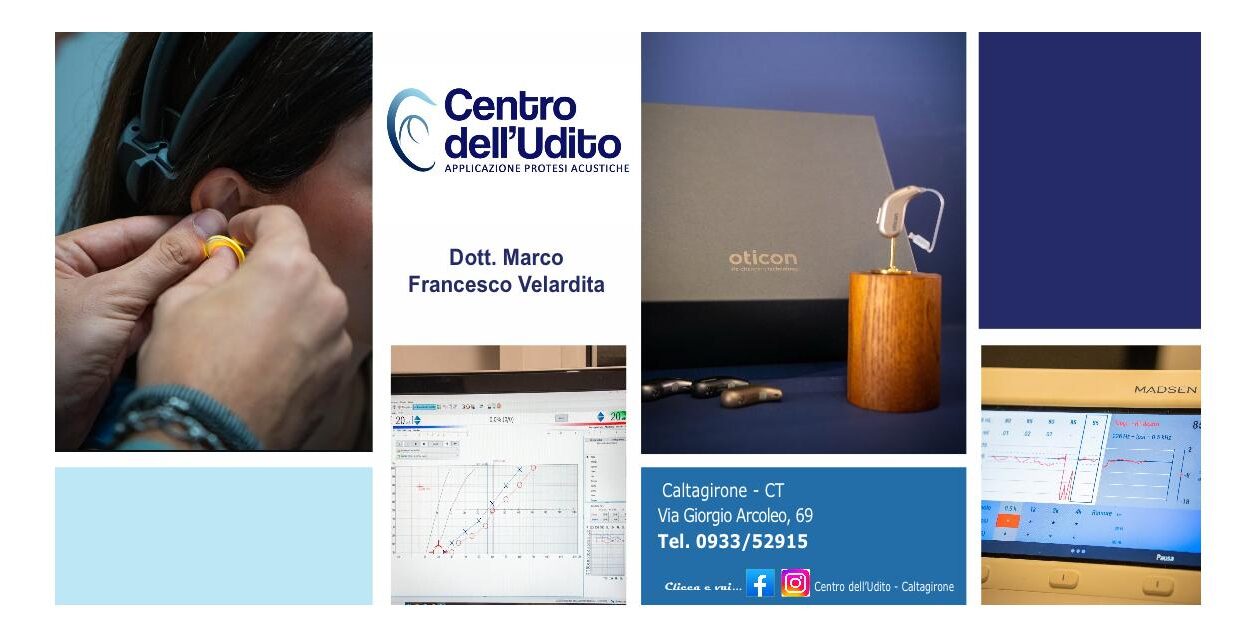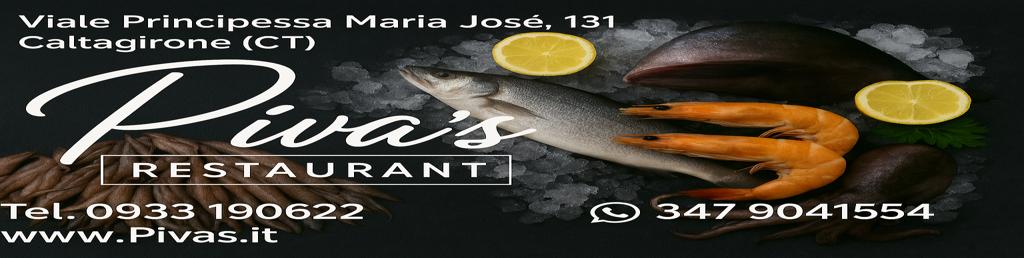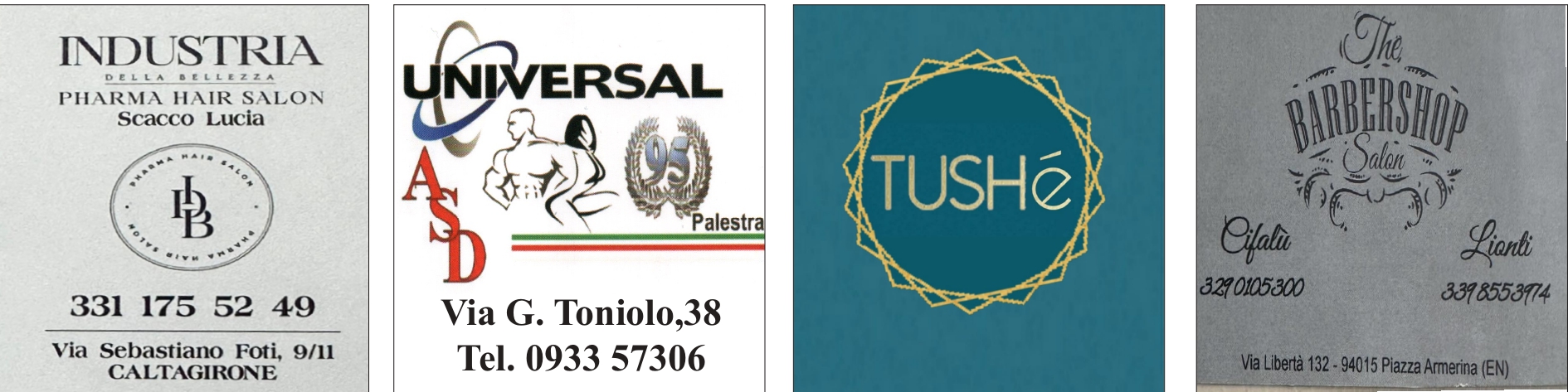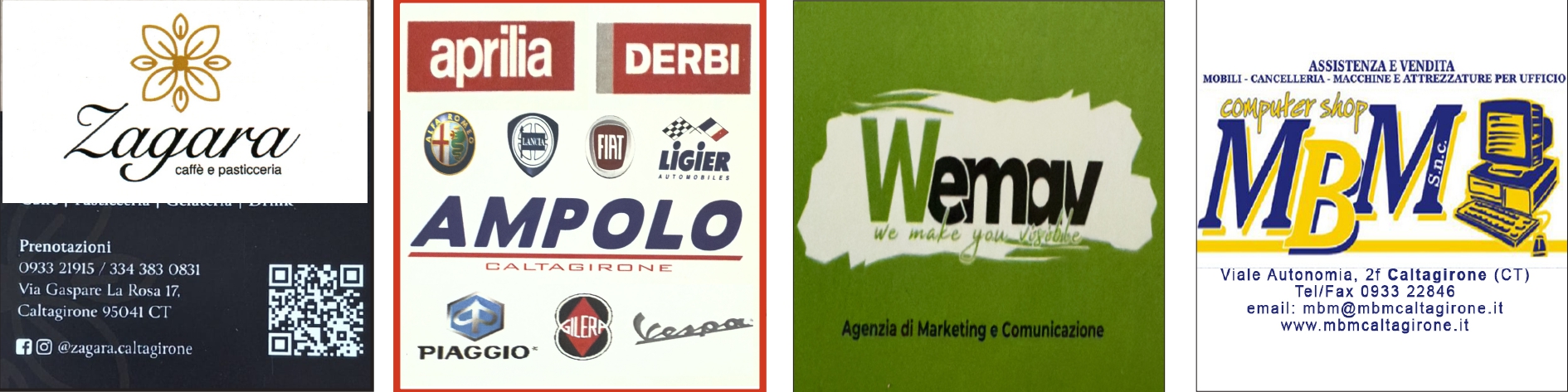Abbiamo avuto il privilegio di intervistare in esclusiva Franco Nicastro, ex consigliere dell’Ordine dei Giornalisti, che ci ha parlato della mostra Testimoni di verità, un’iniziativa dedicata a chi ha messo la propria vita al servizio dell’informazione e della giustizia
Quale dei giornalisti raccontati nella mostra l’ha colpita di più? Perché?
Tutte queste storie colpiscono soprattutto per la brutalità del disegno criminoso con cui sono state soffocate alcune voci libere del giornalismo siciliano. Ma due soprattutto. Una ha come protagonista Giovanni Spampinato con il quale avevo condiviso, giovanissimo, le prime esperienze professionali a Ragusa e provincia. Scrivevamo per il giornale L’Ora, nel quale sarei poi andato a lavorare con vari ruoli. Giovanni Spampinato, con il quale era cresciuto anche un rapporto di amicizia, aveva cercato di trasferire in periferia proprio il modello de L’Ora: un giornalismo di forte impegno, seppure politicamente connotato, che ha pagato un prezzo altissimo per le sue campagne per i diritti civili e contro la mafia e i poteri inquinati. Oltre a una bomba in tipografia, che arrivò nel pieno di un’inchiesta sulla mafia, prima di Giovanni Spampinato erano stati uccisi due giornalisti de L’Ora: Cosimo Cristina, corrispondente da Termini Imerese, e Mauro De Mauro figura iconica di un giornalismo coraggioso e fortemente autonomo.
L’altra storia che ha lasciato un segno profondo nella mia esperienza professionale è quella di Mario Francese, ucciso per le sue inchieste sui nuovi orizzonti della mafia che anticipavano perfino i temi e i risultati investigativi. Grande fu l’orgoglio e anche l’ansia che mi assalì quando toccò proprio a me riprendere al Giornale di Sicilia il suo lavoro di cronista giudiziario.
Che cosa significava per questi giornalisti “dire la verità”? A quale prezzo lo hanno fatto?
Tanti giornalisti uccisi in Sicilia (nove) rivelano un’emergenza sociale e una grande anomalia. Non è accaduto da nessun’altra parte in Italia. E dunque va compreso perché l’informazione sia stata colpita tanto duramente. Una risposta l’ha data il giornale L’Ora che all’indomani dell’uccisione di Giovanni Spampinato ha titolato: “Ucciso perché cercava la verità”. Quel titolo ha un valore paradigmatico perché individua in modo chiaro il senso di quegli omicidi. Ogni caso è maturato in un contesto specifico. Ma c’è un filo che li unisce tutti. Esprimevano una concezione del giornalismo come strumento di ricerca della verità: un giornalismo che è stato un elemento fondamentale del sistema democratico, come rivela l’esperienza della scuola americana.
Cosa ci fa capire questa mostra sul ruolo dell’informazione libera in una società democratica?
Proprio il giornalismo americano ha esercitato il ruolo di un contropotere che tiene sotto controllo tutti gli altri poteri. E lo ha fatto con uno sguardo che ha cercato di intercettare e segnalare i pericoli per la democrazia. Dunque, un contropotere, secondo la concezione di Joseph Pulitzer, al servizio dell’opinione pubblica indicata come giudice naturale dell’informazione. A questa concezione del giornalismo si ispiravano i cronisti siciliani con un ruolo che i poteri criminali hanno cercato di soffocare.
Ha mai visto o vissuto situazioni in cui dire la verità è stato difficile o rischioso? Come si è comportato?
Sì, è capitato. Ma più dell’esperienza personale conta quella di chi ha pagato con la vita il proprio impegno professionale. Percepivo questo pericolo tutte le volte che, per esempio, il lavoro di un collega si spingeva oltre il limite fissato, in modo spesso palese e intomidatorio, dalla mafia. Il caso di Mario Francese è, a questo riguardo, molto indicativo: a lui, come agli altri, non era consentita quella libertà che è l’essenza stessa del giornalismo. E del giornalismo di inchiesta in modo particolare.
In che modo possiamo essere oggi anche noi “testimoni di verità”, nella vita quotidiana, a scuola, online?
Possiamo esserlo in ogni luogo e in ogni occasione. Nella vita quotidiana quando è richiesta una coerenza tra i comportamenti e i principi proclamati. La scuola ha poi un ruolo formativo che ha il compito di indicare i valori della legalità. E devo dire che dalla scuola sono arrivati, e arrivano, segnali importanti. Ne va dato atto ai docenti che investono tanto nella mobilitazione delle coscienze e nella trasmissione di valori fondamentali. E poi c’è l’antimafia alla quale viene chiesto un supplemento di coerenza: non bastano le proclamazioni retoriche e i momenti rituali che diventano spesso foto opportunity.