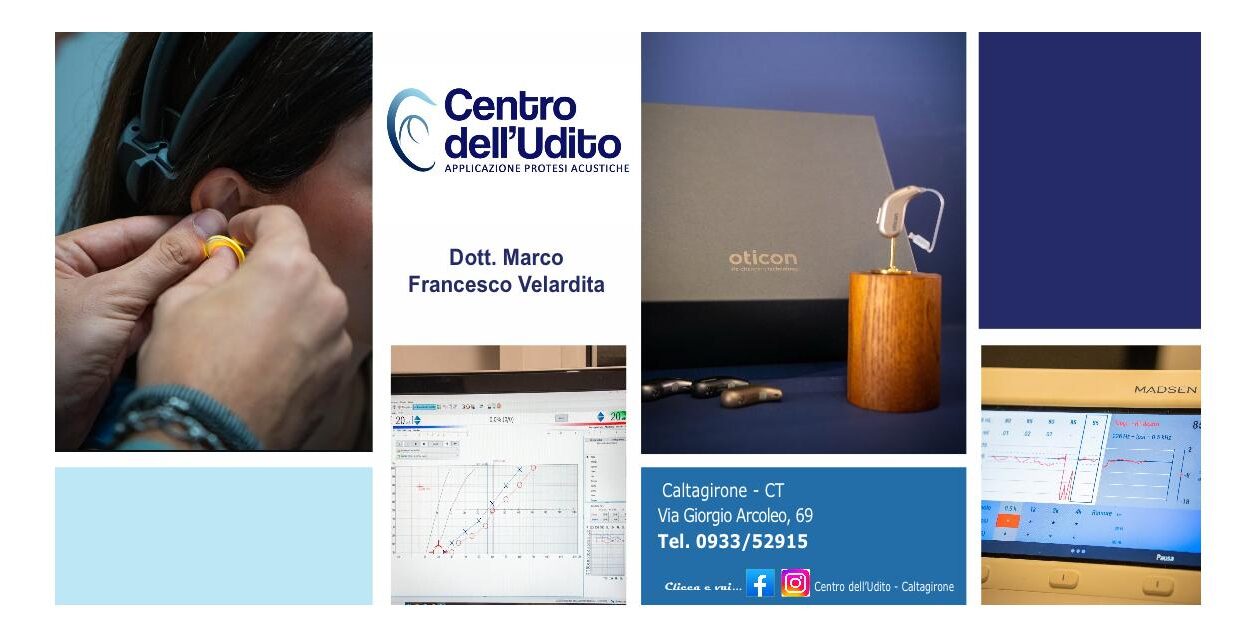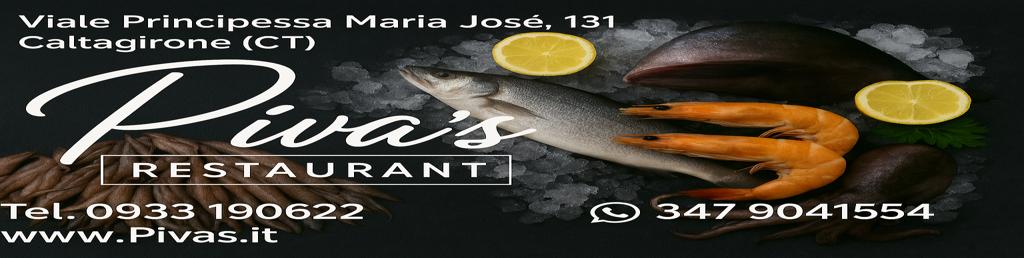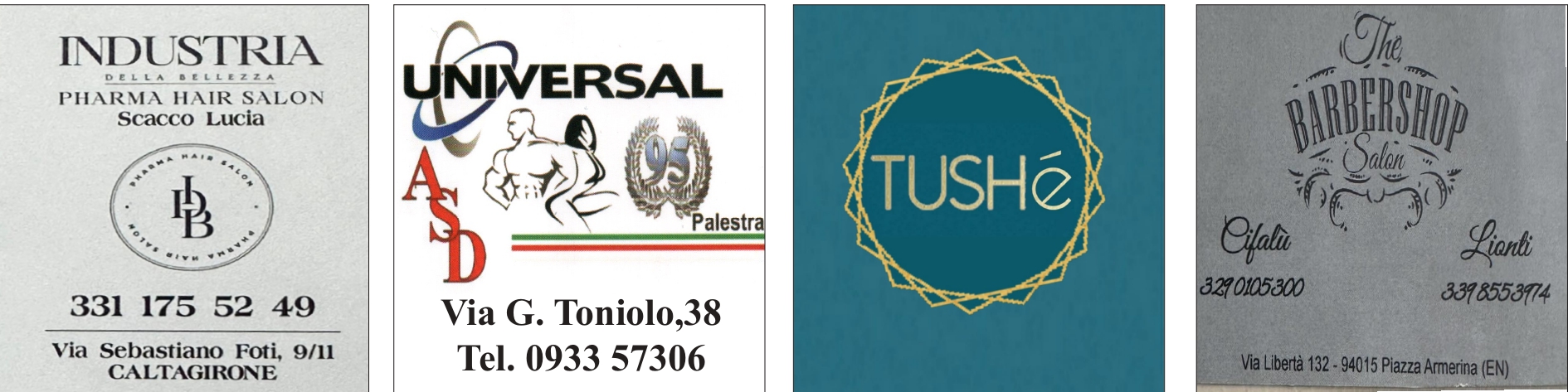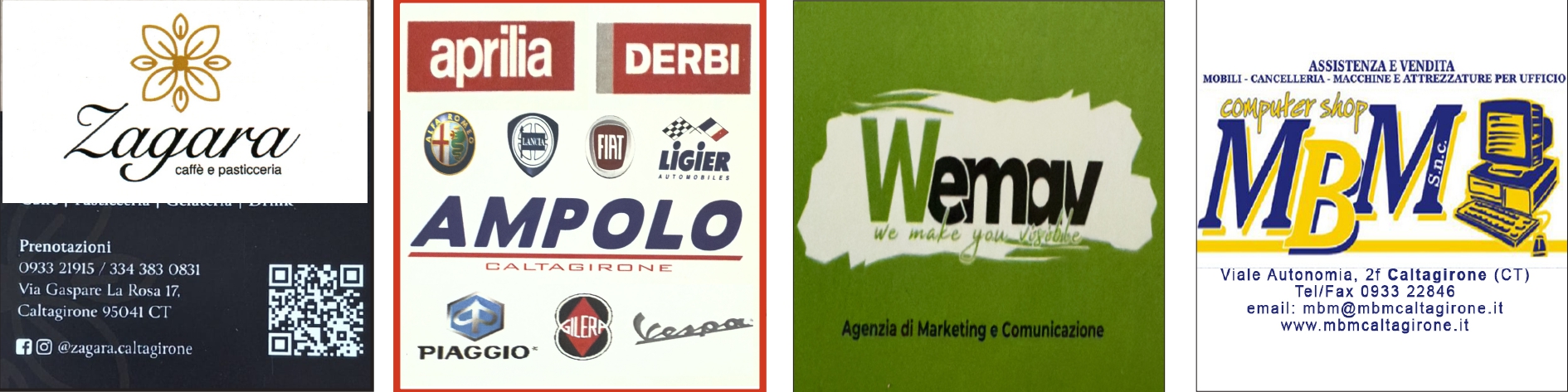Abbiamo intervistato in esclusiva per Prima Stampa Francesco Cesare Riggi, militante di Azione Universitaria, che ci parlerà del sistema scolastico.
Quali sono le principali cause della dispersione scolastica?
Innanzitutto, bisogna partire da un presupposto, che quantomeno dovrebbe portare un leggero ottimismo riguardo al futuro: i dati sulla dispersione scolastica in Italia sono costantemente in calo. Secondo quanto pubblicato dall’istituto INVALSI, dal 25,1% rilevato nel 2000, si è passati al 13,8% nel 2016, al 10,5% nel 2023, e al 9,8% nel 2024. Questo è il sintomo di un’azione efficace da parte del nostro Paese nel contrasto del fenomeno, che lo porta ad avvicinarsi all’attuale media europea (9,3%). Lt’ottimismo tuttavia finisce nel momento in cui andiamo ad analizzare i dati specifici del nostro territorio regionale. La fondazione Openpolis, nel 2023, ha piazzato infatti la Sicilia al secondo posto tra le regioni italiane con la più alta percentuale di abbandono degli studi, con il 17,1% (preceduta soltanto dalla Sardegna). Ed è qui che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione: perché la nostra regione è così problematica su questo punto di vista? C’è da dire che i dati territoriali sulla dispersione scolastica seguono in una certa misura quelli del divario di reddito tra Nord e Sud Italia (tra le ultime posizioni, infatti, troviamo, con alcune eccezioni, esclusivamente regioni meridionali). Sicuramente quindi, una delle cause è di matrice socioeconomica, alla quale però se ne affiancano (o si sovrappongono) altre di diversa natura, che prescindono dal divario Nord-Sud. Secondo l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, tra le ulteriori cause rilevanti della dispersione scolastica, vi sono condizioni familiari instabili (genitori separati, tossicodipendenti, violenti, sottoposti a procedimenti giudiziari etc…), disagi personali psico-emotivi dei giovani, difficoltà relazionali coi coetanei, e, nel caso specifico degli studenti stranieri (tra i quali il tasso di abbandono è decisamente più elevato), la mancata integrazione nel nostro tessuto socioculturale. Questo completa tutto sommato il quadro di un problema dal grande rilievo, che se lo Stato Italiano sta affrontando negli ultimi decenni in maniera efficace, tuttavia lascia ancora delle lacune che non possono essere ignorate, specie nella nostra regione.
In che modo il sovraffollamento delle classi può influire sulla qualità dell’apprendimento?
Quello delle cosiddette “classi pollaio” è un problema sicuramente sottovalutato. Partiamo intanto dal chiarire il concetto in sé, andando a dare un’occhiata alla normativa: il DPR n. 81 del 2009 stabilisce chiaramente il numero massimo di studenti assegnabili per singola classe (a seconda del grado). A titolo puramente esemplificativo, prendiamo il caso della scuola secondaria di primo grado (i valori comunque si discostano di poco tra un grado e l’altro), per la quale è stabilito un tetto massimo di 27 alunni per ogni classe (elevabile a 28, in caso di eventuali bocciature di studenti negli anni successivi). Superata questa soglia, si può parlare a pieno titolo di “sovraffollamento”. Ecco: secondo le elaborazioni del Centro Studi Orizzonte Scuola, le “classi pollaio” in Italia corrispondono a quasi il 2% del totale. Se la percentuale può comunque sembrare di poca rilevanza, andare a guardare il numero assoluto può invece evidenziare le reali dimensioni del problema: parliamo di un totale di 6.225 classi. Il rilievo così è sicuramente notevole, perché ci permette di calcolare che probabilmente il numero di alunni costretti a studiare in questa condizione inadatta non sia lontano dalle 200.000 unità. I difetti nell’apprendimento a cui sono sottoposti tali studenti sono molteplici, ma tra questi, il più rilevante è sicuramente la dispersività delle lezioni, dato che gli insegnanti si trovano necessariamente in difficoltà a seguire con attenzione un numero eccessivamente elevato di alunni. Naturalmente, qualora dovessero esserci problemi nell’apprendimento di un concetto, di un argomento o anche di un’intera materia, è possibile intervenire in maniera mirata solo se la classe dovesse essere contenuta nelle sue dimensioni, in maniera tale che il docente abbia modo di verificare costantemente le competenze dei suoi studenti, ed eventualmente rendersi conto delle loro lacune. Allo stesso modo, gli alunni, presi singolarmente, potrebbero interagire in maniera costante con il proprio insegnante, chiedendo chiarimenti e spiegazioni in caso di dubbio, solo se non dovessero esserci altri di loro (in numero eccessivo) con la stessa necessità. In assenza di queste condizioni, è fisiologico che qualcuno resti sempre indietro rispetto al programma, e che dopo un po’ non riesca più a recuperare. Ma appunto, se la causa è il sovraffollamento della classe, difficilmente la colpa può essere attribuita all’insegnante. Addirittura c’è chi, come il filosofo Umberto Galimberti, propone di dimezzare il numero massimo di studenti per classe attualmente previsto dalla normativa, riducendolo a 10-15, sostenendo che solamente così si potrebbe dar modo ai maestri e ai professori di curare al meglio l’apprendimento. Ovviamente, una soluzione del genere è oggi impossibile, ma proprio per via di quanto sopra esplicato, cercare quantomeno di eliminare completamente il problema delle “classi pollaio”, e magari cercare di rivedere leggermente al ribasso i tetti-limite di alunni per classe, sarebbe fondamentale.
Quali difficoltà incontrano gli studenti con bisogni educativi speciali se non ricevono adeguato supporto?
Volendo, questa domanda si collega alla risposta fornita in precedenza. Quella di prestare la necessaria attenzione ad ogni singolo studente, supervisionandone in maniera costante l’apprendimento, è una questione fondamentale. Nel caso degli studenti con “bisogni educativi speciali” (quelli che, per problemi di natura fisica, psicologica, sociale o di altro tipo, necessitano di un supporto addizionale per colmare delle difficoltà nell’apprendimento rispetto ai loro coetanei), l’attenzione che bisogna prestare è ovviamente ancora maggiore. Trattandosi di soggetti dalla condizione precaria, l’assenza del supporto necessario può portare non solo a danneggiare l’apprendimento, ma anche a conseguenze forse più gravi, come il loro isolamento all’interno della classe, la chiusura in sé stessi, oppure ancora, ricollegandoci a quanto detto inizialmente, anche l’abbandono degli studi vero e proprio. Per tale motivo, non bisogna prendere sotto gamba la necessità di dedicare gli adeguati trattamenti a questi soggetti “speciali” che fanno pur parte del nostro stesso sistema scolastico.
Come influisce la mancanza di aggiornamento tecnologico nelle scuole sull’apprendimento?
Al di fuori della scuola, il progresso tecnologico sta avanzando imperterrito, a gran velocità, e non sembra sicuramente in procinto di fermarsi. Ora, al di là della sua eticità o meno e delle conseguenze future a cui porterà questo progresso, il mondo scolastico non può rimanere indietro, quasi isolandosi in una bolla rispetto a ciò che avviene esternamente, e quindi deve necessariamente evolversi nel corso del tempo. Sono stati fatti grandi passi avanti nell’ultimo decennio: dall’introduzione delle lavagne interattive alla sostituzione del registro cartaceo con quello elettronico, fino alle più recenti integrazioni della didattica fisica vera e propria con i materiali messi a disposizione dagli insegnanti su apposite piattaforme multimediali. Insomma, la scuola sta andando avanti. Tuttavia, la sua evoluzione è più lenta rispetto a quella della società, e questo è un fatto incontestabile. Il rischio diretto riguardante l’apprendimento riguarda un eventuale spaesamento che potrebbe crearsi nello “sbalzo” degli studenti tra un mondo esterno molto avanzato dal punto di vista tecnologico, e una scuola che invece mantiene il proprio assetto e non progredisce alla stessa velocità. Portiamo un esempio pratico, che può certamente apparire estremo, provocatorio e paradossale (lo è): nella vita di tutti i giorni, quasi nessuno scrive più con carta e penna. Questi strumenti ormai sono stati surclassati dai supporti elettronici, e chiunque, dovendosi appuntare qualcosa, lo fa, nel 90% dei casi, su un blocco-note digitale. Ha senso quindi continuare a costringere gli studenti ad utilizzare carta e penna per prendere appunti e svolgere i compiti in classe? Sottolineo che si tratta chiaramente di una provocazione, e che io stesso sarei eticamente contrario ad abolire la scrittura a mano nel mondo scolastico per correre dietro all’evoluzione dei tempi. Tuttavia, se vogliamo parlare effettivamente di “scuola al passo coi tempi” (anche se spesso non è chiaro cosa si intenda dire), porsi queste domande estreme, e anche fastidiose, assume un significato fondamentale.
Quali sono gli effetti della carenza di insegnanti qualificati sul rendimento scolastico?
Da studente universitario di storia, mi voglio prendere un attimo per spezzare una lancia in favore dei miei futuri colleghi: nell’attuale periodo, più che la “carenza di insegnanti qualificati”, un problema maggiore è costituito dalla carenza di insegnanti in generale. La rete europea Eurydice ha sottolineato la mancanza di un adeguato ricambio generazionale nel mondo scolastico, rilevando che in Italia solamente il 6,4% dei docenti abbia meno di 35 anni. Tra lo stress oggi richiesto dall’insegnamento, gli stipendi ben al di sotto della media europea, i contratti spesso a tempo determinato (che raggiungono addirittura un terzo del totale nella fascia 35-49 anni!) e una precaria salute del sistema scolastico in generale, di sicuro quello del docente non è un lavoro tra i prediletti in Italia. E da ciò, derivano le carenze di personale. Chiusa questa parentesi, voglio però ricollegarmi alla domanda vera e propria, partendo però sempre dalla questione dei salari: bassi stipendi comportano basse prestazioni. Secondo il rapporto completo dell’Eurydice per l’a.s. 2020/2021, gli stipendi iniziali degli insegnanti italiani sono più bassi del 25% rispetto a quelli dei loro colleghi spagnoli, e sono addirittura meno della metà in valore rispetto a quelli percepiti dai tedeschi. Spesso quindi, il problema dei docenti non è la mancanza di qualifica per svolgere il proprio lavoro (l’iter abilitativo necessario è infatti lungo e complesso), ma la carenza di motivazione, essendo ben coscienti che moltiplicare gli sforzi non provochi un aumento proporzionale di quel risicato salario. La questione ovviamente non si può ridurre ad una mera matrice economica, dato che globalmente agiscono anche altri fattori, ma è innegabile che il sistema scolastico richieda ai docenti un’elevata motivazione, che alcuni non riescono a mantenere. Questo comporta delle conseguenze pesanti nella qualità dell’insegnamento, e consequenzialmente nell’apprendimento da parte degli alunni. Un docente poco motivato trasmetterà con difficoltà agli studenti l’interesse necessario per seguire le proprie lezioni, a prescindere da tutte le qualifiche che abbia acquisito durante l’abilitazione professionale. Poi effettivamente sì, esiste un problema legato ad alcuni insegnanti meno qualificati, ma che comunque esercitano la propria professione. Nello specifico, parliamo per esempio di casi in cui la chiarezza espositiva sia carente, di altri in cui l’empatia nei confronti degli studenti non sia sufficiente, oppure di altri ancora in cui l’insegnante non sia, per vari motivi, sufficientemente portato per gestire una classe. In tutti questi casi, i danni sull’apprendimento e sul rendimento degli alunni sono senza dubbio ancora più profondi. Tuttavia, è chiaramente difficile per il sistema scolastico agire al fine di valutare singolarmente la qualità degli oltre 700.000 insegnanti che ne fanno parte.